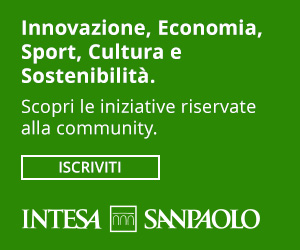Piove o non piove, il governo sempre ladro è, come recita il proverbio popolare. Ma la dura “lezione” della siccità insegna che anche noi, semplici cittadini e comuni mortali, abbiamo le nostre responsabilità. Quando sprechiamo l’acqua, innanzitutto, consumandone una quantità eccessiva; lasciando i rubinetti aperti o non chiudendoli come si deve; caricando a metà lavatrici e lavastoviglie; innaffiando indiscriminatamente terrazzi e giardini. Ma anche quando riteniamo che l’acqua sia un “bene pubblico” a disposizione di tutti ventiquattr’ore su ventiquattro e come tale debba essere totalmente gratuito.
L’ho sostenuto anch’io all’epoca del referendum e ora ne faccio qui parziale ammenda. Non tanto perché l’idea sia infondata o arbitraria. Quanto per il fatto che risulta diseducativa: un bene a basso prezzo è un bene di basso valore. Se non si paga o si paga poco, non costa. E invece, una risorsa vitale come questa, tanto più perché è ridotta e limitata, costa in termini di servizi, cioè di raccolta, impianti e distribuzione, come l’energia elettrica o il gas.
Un bene di tutti rischia così di diventare un bene di nessuno. Da “res omnium” a “res nullius”. È la dissipazione collettiva di un “bene comune” che appartiene all’intera umanità. E si può considerare una nemesi storica il fatto che i romani, inventori e costruttori degli acquedotti in tutto il mondo antico, debbano rischiare adesso di essere sottoposti al razionamento a giorni alterni.
Naturalmente, bisogna distinguere fra la “proprietà” pubblica dell’acqua e la sua “gestione” che può essere pubblica o privata, a seconda delle situazioni. Senza approcci ideologici o “guerre di religione”. Non mancano casi in cui la gestione privata risulta anche più efficiente ed economica di quella pubblica o viceversa. Ma, comunque, occorre migliorare tutta la rete nazionale per evitare il fenomeno della dispersione che in alcune regioni arriva addirittura al 40 per cento e oltre della fornitura.
Dal momento che si tratta di un bene fondamentale, di una risorsa irrinunciabile, il prezzo dev’essere ragionevolmente rapportato – oltre che ai consumi effettivi – anche al reddito individuale e alle condizioni anagrafiche ed economiche delle famiglie. Un prezzo amministrato è per definizione un “prezzo politico”. Ma una tariffa progressiva può risultare socialmente più equa e “pedagogica”, favorendo la riduzione degli sprechi e il risparmio idrico nella vita quotidiana di ciascuno di noi.
La questione riguarda in particolare le regioni meridionali, a cominciare dalla Puglia “sitibonda” – come la definì il poeta Orazio – che in realtà è l’unica a non disporre di acqua propria perché non ha rilievi montuosi. Ed è perciò tributaria della Campania e della Basilicata, attraverso il più grande acquedotto d’Europa. Per le altre, dalla Calabria che invece è una regione prevalentemente montuosa fino alla Sicilia e alla Sardegna, occorre ammodernare e monitorare gli impianti per impedire le perdite e i furti sulla rete. Per tutto il nostro Mezzogiorno, dalla produzione agricola all’allevamento del bestiame e infine al turismo, si tratta di una condizione essenziale di sopravvivenza e di sviluppo.
Abbiamo surriscaldato il Pianeta con le emissioni nocive e i gas serra, provocando il buco dell’ozono. E ora ne paghiamo le conseguenze: la temperatura si alza, i ghiacciai si sciolgono e purtroppo piove di meno. O peggio, quando piove, arrivano i rovesci e le “bombe d’acqua”; cadono le piogge brevi, intense e torrenziali tipiche dei climi tropicali, ma fanno più male che bene alle campagne e al territorio. Non è una fatalità e non è colpa soltanto del “governo ladro”.
Se è vero che non tutti i mali vengono per nuocere, anche la siccità di questa estate 2017 può lanciare un richiamo generale alla responsabilità ecologica. La sua “lezione” deve indurci a modificare le cattive abitudini della società contemporanea, a consumare meno acqua e a utilizzarla meglio. Non basta chiedere lo “stato di calamità” quando i danni purtroppo sono stati già fatti. Occorre prevenire le reazioni della natura alle offese prodotte dall’uomo, correggendo i nostri comportamenti e rimuovendo all’origine le cause che provocano questi fenomeni catastrofici.
Giovanni Valentini
(da “La Gazzetta del Mezzogiorno” del 26 luglio 2017)