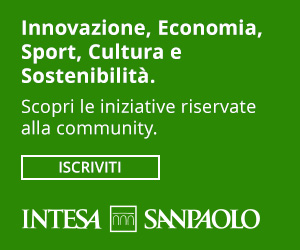L’ultima scadenza, tassativa e inderogabile, era stata fissata al 31 dicembre 2023. Poi, il governo ha concesso una deroga di un anno in caso di “difficoltà oggettive e documentate da parte dei Comuni costieri”. Ma è passato anche il 2024 e ora si attende entro il 31 marzo l’approvazione del decreto attuativo sugli indennizzi ai gestori degli impianti balneari che dovrebbe sbloccare l’impasse (la foto in alto è tratta dal sito “Mondo Balneare”).
La questione delle concessioni era stata già definita nel 2006 dalla direttiva europea firmata dal commissario Frits Bolkestein, in forza della normativa sulla concorrenza. Ed è relativamente semplice: le spiagge appartengono al demanio di ciascun Paese e quindi vanno messe a gara. Altrettanto chiaro è il fatto che gli ex concessionari hanno diritto a un indennizzo economico per gli investimenti effettuati e non ancora ammortizzati.
Ma ora il governo, nella bozza del decreto predisposto dal ministero delle Infrastrutture, stabilisce che venga aggiunta anche l’equa remunerazione su quelli effettuati negli ultimi cinque anni, sfidando le indicazioni di Bruxelles. Una sorta di indennizzo supplementare, insomma, per i balneari che perderanno le proprie concessioni in seguito alle gare. La Commissione europea, invece, nelle sue osservazioni al testo del decreto aveva chiesto all’Italia di concedere solo la copertura degli investimenti non ammortizzati.

In Italia, i vari governi che si sono succeduti dal 2006 a oggi non hanno fatto altro che prorogare di anno in anno la scadenza originaria. E di fronte a questi continui rinvii, è intervenuta anche l’Agcm, la nostra Autorità di garanzia sul mercato e sulla concorrenza, per dichiarare che non era più ammessa alcuna deroga.
Ma, evidentemente, la “lobby dei balneari” è tanto forte sul piano elettorale da indurre il vicepremier e ministro dei Trasporti e delle Infrastrutture, Matteo Salvini, a cavalcare la protesta predisponendo un decreto “salva-infrazioni” in modo da individuare i criteri per una “equa remunerazione” e tutelare gli interessi dei gestori. Con questo provvedimento, il governo punta a disporre che le gare pubbliche per l’assegnazione delle concessioni vengano indette entro il 30 giugno 2027.

A rimetterci, in questo braccio di ferro, sono sicuramente i cittadini che si apprestano ancora una volta ad affrontare la nuova stagione estiva senza la certezza di poter disporre liberamente delle spiagge e di pagare i servizi (ombrelloni, sedie a sdraio, lettino, bagni e docce) il giusto prezzo stabilito dal mercato. Con oltre ottomila chilometri di coste, l’Italia sarebbe in grado di offrire un’adeguata ospitalità al popolo dei vacanzieri e dei turisti. Ma bisogna individuare anche una percentuale corretta dei lidi da assegnare in concessione rispetto all’intero litorale.
Non è un mistero per nessuno che finora i gestori degli stabilimenti hanno versato canoni irrisori allo Stato. E nel 2024, in base all’inflazione, sono stati più bassi del 4,5% rispetto all’anno precedente: il canone minimo è sceso da 3.377,50 euro a 3.225,50 all’anno. Ma il ministero ha precisato che questi dati riguardano solo un numero esiguo di concessioni e non si riferiscono agli stabilimenti balneari, bensì altre tipologie di utilizzo di micro-porzioni di demanio marittimo, come per ormeggi, gavitelli, vialetti d’accesso al mare e attività no-profit.

Fatto sta che lo Stato incassa in totale poco più di 100 milioni di euro all’anno, mentre il giro d’affari complessivo dei gestori è stato stimato intorno ai 15 miliardi. Un esempio per tutti: il lido “L’Ultima Spiaggia” di Capalbio, fra i più conosciuti della Toscana, un ombrellone costa sui 55 euro al giorno, che per quattro mesi estivi di stagione balneare corrispondono a un incasso di oltre 6 mila euro. Secondo i dati di Legambiente, il canone annuo che lo stabilimento corrisponde allo Stato è di 6.098 euro.
È solo l’apertura al mercato e alla concorrenza, dunque, che può determinare costi e ricavi più equi per tutti. Ma, dalla direttiva Bolkestein a oggi, sono ormai quasi vent’anni che l’Italia non si adegua. E intanto aumenta il rischio di procedure d’infrazione da parte dell’Unione europea, con conseguenti sanzioni a carico dell’Italia.